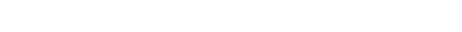Le spese del processo tributario
Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
LE SPESE DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Aggiornamento Marzo 2017)
La regolamentazione delle spese del processo tributario è contenuta negli articoli 15, 44, 45 e 46 del Dlgs. 546/92 (come modificato dal Dlgs 156/2015), nonché negli artt. da 137 a 141 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (TUSG) per il patrocinio a spese dello Stato e, infine, per quanto non specificamente previsto, per il rinvio di cui all’art.1 Dlgs 546/92, dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile relative alle spese del processo.
La norma basilare è l’art.15 Dlgs 546/92 che, nel ribadire il principio di responsabilità per le spese del processo, conferma il criterio della soccombenza per la imputazione delle stesse ed il conseguente potere del giudice di compensarle, potere che però, come si dirà più precisamente di seguito, a differenza che nella previgente formulazione della norma, è condizionato dalla sussistenza di precise condizioni.
Con il citato art.15 viene poi introdotta ufficialmente nel processo tributario la c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria, prendendosi atto della costante interpretazione giurisprudenziale che già la riteneva applicabile sulla base del generico rinvio alle norme del processo civile contenuto nell’art.1, comma 2, del Dlgs.546/92.
E’ inoltre espressamente previsto che l’ordinanza cautelare deve contenere anche la statuizione delle spese per la relativa fase.
Sono poi indicati i vari elementi che compongono le spese di giudizio sia per i difensori dei contribuenti che per quelli degli enti impositori o della riscossione, mentre la concreta determinazione degli stessi è regolamentata nel TUSG (per quanto concerne il contributo unificato) e in appositi decreti ministeriali (per quanto concerne il compenso dei difensori).
Nel penultimo comma dell’articolo è contenuta la disposizione (già in precedenza allocata nell’art.17 bis concernente il reclamo/mediazione) relativa alla maggiorazione delle spese per la fase del reclamo a carico della parte che risulti soccombente nel giudizio.
Infine nell’ultimo comma è contenuta la regolamentazione delle spese in relazione all’esito, positivo o meno, di una proposta di conciliazione.
Gli artt. 44, 45 e 46 contengono la disciplina delle spese per le varie ipotesi di estinzione del processo, ovvero per rinuncia al ricorso (art.44), per inattività delle parti (art.45) e per cessazione della materia del contendere.
1) LE SPESE DEL GIUDIZIO (art.15 Dlgs 546/92)
A) il principio di soccombenza
Ai sensi del primo comma dell’art.15 Dlgs.546/92 “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”.
Il principio di soccombenza esiste da antica data nel processo civile ed è stato integralmente recepito nel processo tributario. Esso non ha natura sanzionatoria e non costituisce nemmeno risarcimento del danno (v. Cass. 189/2017) ma è nel contempo applicazione del principio di causalità, poiché è chi ha dato causa al processo, in cui l’altra parte è risultata vincitrice, che deve sopportarne gli oneri, nonché dei principi costituzionali del diritto di difesa (art.24 Cost.) e del giusto processo (art.111 Cost.) poiché il diritto di colui che risulta vincitore sarebbe seriamente pregiudicato, e quindi non potrebbe considerarsi effettivo, se egli, per ottenere la tutela processuale, fosse costretto in definitiva a sostenere le spese processuali, con ciò subendo un evidente pregiudizio patrimoniale.
E’ bene precisare che la parte vittoriosa deve essere individuata in relazione all’esito complessivo e finale della controversia giudiziaria (Cass.4201/2002), esito che può essere determinato da motivi di merito o anche meramente processuali (Cass.10911/2001).
La ratio della norma consiste nella doverosa esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che, per vedere riconosciuto il proprio diritto, deve svolgere attività processuale con i conseguenti costi: l’omesso riconoscimento delle spese di lite (es. € 20,00) sostenute per tutelare il proprio diritto (es. € 100,00) comporterebbe l’evidente conseguenza del riconoscimento da parte dello Stato solo dell’80% del diritto fatto valere il che, oltre a contrastare con il principio del giusto processo, comprometterebbe seriamente il diritto di difesa al quale, ad esempio, il contribuente si vedrebbe costretto a rinunciare (per evidenti motivi di convenienza economica) per il caso, non infrequente, che il diritto da azionare abbia valore economico inferiore alle spese di giudizio.
Come efficacemente osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (v. Cass. 930/2015 e 373/2015) la giustificazione del principio di soccombenza è agevolmente comprensibile ove si consideri da un lato che colui che risulta vittorioso nel processo deve vedersi riconosciuto il suo diritto integro e non diminuito delle spese di causa e, dall’altro, che colui che rimane soccombente dimostra di avere senza ragione causato una lite, o per avere proposto una domanda infondata o per avere ingiustamente resistito ad una domanda che era fondata.
Deve comunque rilevarsi che la soccombenza può conseguire non solo a valutazioni di merito ma anche a ragioni puramente processuali (es. ricorso inammissibile) ed anche al rigetto di reclamo avverso un provvedimento del giudice
E’ da precisare, poi, che la soccombenza deve essere valutata in senso oggettivo, non avendo alcun rilievo l’elemento psicologico delle parti (elemento che invece rileva, come si vedrà, ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria) e, pertanto, nemmeno la omessa costituzione del soccombente o il riconoscimento della fondatezza dell’avversa pretesa.
Quindi non già esigenza di punizione, ma solo esigenza di ripristinare integralmente il diritto della parte vittoriosa.
La soccombenza, poi, può essere totale, se sono rigettate tutte le domande proposte, o parziale, se sono rigettate alcune delle domande proposte. In tale ultimo caso, che comunque comporta una valutazione della lite nel suo complesso, il giudice, con valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (salvo che sia fondata su ragioni illogiche e contraddittorie) può compensare parzialmente le spese di lite. Invero, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 19880/2011 e 1703/2013).
In caso di pluralità di soccombenti la condanna alle spese va ripartita, ex art.97 c.p.c., in relazione all’interesse di ciascuna o, in caso di interesse comune, in via solidale a carico di tutte o di alcune tra esse.
Se sussistono rapporti autonomi tra le parti soccombenti, anche nell’ipotesi di litisconsorzio originario o successivo, la liquidazione è fatta con riferimento a ciascuna domanda (Cass. 7674/2009).
In caso di chiamata in causa di un terzo anche ad esso devono essere rifuse le spese, anche se non chiamato dal soccombente (Cass.7674/2008).
Deve comunque essere precisato che in nessun caso possono essere liquidate spese che non siano state effettuate. Infatti nell’ipotesi che il contribuente, essendogli consentito (processo avente valore inferiore ad € 3.000,00 ex art.12 Dlgs 546/92), agisca senza l’assistenza di difensore, in caso di soccombenza dell’ente convenuto possono essere liquidate solo le spese vive (es.contributo unificato), a meno che non si tratti di soggetto abilitato alla difesa tecnica, poiché la facoltà di difesa personale non può incidere sulla natura professionale dell’attività espletata né sulla qualificabilità come spese di giudizio dei diritti e degli onorari previsti per la sua prestazione (Cass 2193/2008).
Va altresì precisato che l’anticipazione delle spese può essere disposta in corso di causa a favore del consulente tecnico (nominato ex art.7 Dlgs 546/92) e, generalmente, essendo ancora incerto l’esito del processo, è posta a carico di entrambe le parti in pari misura.
Il capo della sentenza che contiene la condanna alle spese anche se, ovviamente, consegue a quello relativo al merito del processo, è da quest’ultimo autonomo, sì che la sentenza può essere impugnata anche per la sola soccombenza per le spese (ad es. liquidate in misura inferiore a quella richiesta e dovuta), e tanto a prescindere dalla impugnabilità del capo relativo al merito.
Si deve rilevare, infine, una evidente disparità di trattamento, operata nel processo tributario dal Dlgs 156/2015, in materia di esecutività del capo della sentenza tributaria contenente la condanna alle spese.
Ai sensi dell’art.69 Dlgs 546/92 (come novellato dal Dlgs 156 cit) la condanna alle spese in favore del contribuente, contenuta in una sentenza non ancora passata in giudicato, è provvisoriamente esecutiva senza alcun limite di somma, poichè la condizione della prestazione di garanzia imposta per la condanna in favore del contribuente a somme superiori ad € 10.000,00 (garanzia il cui contenuto è determinato nel DM n.22/2017 a decorrere dal 28/3/2017) è espressamente esclusa dalla norma per le spese (“diverse dalle spese di lite”).
Invece nell’ipotesi di condanna a favore dell’ente la riscossione deve avvenire mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, come testualmente dispone l’art.15, comma 2 sexies, ultima parte del Dlgs 546/92.
La disparità di trattamento tra contribuente ed A.F. è del tutto evidente e non può non rilevarsi che essa tradisce (stranamente una volta tanto in favore del contribuente) il principio della parità delle parti nel processo posto dall’art.111 della Costituzione e ribadito dalla Legge delega n.23/2014 che all’art.10, comma 10, impone al legislatore delegato di assicurare la “previsione della immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.
Da ultimo giova ricordare che è stato ritenuto che la controversia sulla debenza delle spese processuali determinate in un precedente giudizio tributario è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie (S.U. 14554/2015), e questo perché le spese di giustizia rientrano tra “gli altri accessori nelle materie di cui al comma 1” dell’art.2 del Dlgs 546/92, disposizione questa che elenca le materie rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
B) la compensazione delle spese
Dispone il comma secondo dell’art.15 Dlgs 546/92 che “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
L’istituto della compensazione delle spese di lite, che il processo tributario ha tratto dal processo civile, costituisce, come meglio si dirà di seguito, una sorta di valvola per temperare il generale principio di soccombenza posto, in via generale, dall’art.91 c.p.c., per il processo civile e dall’art.15, I comma prima parte, del Dlgs 546/92, per il processo tributario.
Nella originaria formulazione dell’art.15 cit. la compensazione delle spese nel processo tributario era regolamentata mediante rinvio all’art.92 c.p.c. che testualmente così disponeva: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite tra le parti”.
Orbene, quanto alla compensazione delle spese per l’ipotesi di soccombenza reciproca, va innanzitutto rilevato che nel processo tributario, che è processo sull’atto e quindi di natura impugnatoria, l’unico caso di soccombenza reciproca è costituito dall’accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente, potendosi però verificare la soccombenza parziale a carico di entrambe le parti nella fase dell’impugnazione (es.: accoglimento solo parziale sia dell’appello principale che dell’appello incidentale della parte appellata).
In relazione, poi, alla quantificazione delle spese, che deve essere commisurata alla percentuale di soccombenza, si rileva che detta percentuale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che, se immune da motivazione illogica o erronea, non è sindacabile in sede di legittimità.
Invece per la originaria ipotesi della ricorrenza dei giusti motivi la giurisprudenza, quasi all’unanimità, si pronunciava per la non necessarietà della motivazione specifica assumendo che, trattandosi di pronuncia accessoria, i motivi potevano essere dedotti dalla complessiva motivazione della sentenza.
Purtroppo il predetto insegnamento giurisprudenziale generava un manifesto abuso dei giudici nella regolamentazione delle spese di giudizio, abuso che sovente si traduceva nell’arbitrio, tanto da indurre il legislatore a riformare la norma di cui all’art.92, II comma, c.p.c. (applicabile, si ricorda, al processo tributario per il rinvio contenuto nell’art.15 cit) che, in esito alle modifiche introdotte con la legge n.263/2005, risultò così formulata: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione…”.
Con tale innovazione il legislatore manifestava chiaramente la volontà di ridurre il ricorso alla apodittica compensazione delle spese, con le usuali formule “sussistono giusti motivi” oppure “si ritiene equo”, imponendo al giudice di indicare nella motivazione quali fossero i giusti motivi, e tanto con la duplice finalità che non fossero lesi i diritti della parte vittoriosa e che fosse ridotto il carico del contenzioso spesso determinato da intenti pretestuosi e dilatori.
Purtroppo la manifestata volontà del legislatore non trovava accoglimento da parte dei giudici che si dimostravano ostinatamente restii ad abbandonare la consolidata prassi delle sentenze del tutto immotivate o stereotipatamene motivate in punto di compensazione delle spese, sì che si rese necessario un nuovo e più decisivo intervento del legislatore che, in occasione della riforma del codice di procedura civile, attuato con la legge n.69 del 2009, riformulò ancora una volta il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. (si ricorda applicabile al processo tributario ex art.15 Dlgs 546/92) che risultò così formulato: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione…”.
Pertanto nel processo tributario a decorrere dall’anno 2009 la compensazione delle spese processuali era possibile che fosse disposta solo o in caso di soccombenza reciproca o in caso di ricorrenza di ragioni gravi ed eccezionali da indicare espressamente nella motivazione della sentenza.
La situazione ha subito ulteriore modifica sia nel processo civile che nel processo tributario.
Invero nel processo civile con l’art.13, comma 1, del DL 132/2014, è stato disposto (con decorrenza dall’entrata in vigore della legge di conversione n.162 del 10 novembre 2014) che la compensazione delle spese, totale o parziale, è possibile “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…”.
Nel processo tributario, con la riforma attuata con il Dlgs n.156 del 24 settembre del 2015, a decorrere dal 01 gennaio 2016, la regolamentazione delle spese è diventata autonoma, sganciandosi dal rinvio al codice di procedura civile, ed è contenuta nel nuovo comma 2 dell’art.15 Dlgs 546/92 che testualmente dispone: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Come risulta evidente, pertanto, per effetto del rinvio al codice di procedura civile contenuto nell’art.15 Dlgs 546/92, fino alla riforma attuata con il Dlgs 156/2015, nel processo tributario dall’anno 2009 fino all’anno 2014 la compensazione delle spese era possibile (oltre che per soccombenza reciproca) solo nell’ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione.
Dal novembre 2014 al 01 gennaio 2016 era possibile (oltre che per la soccombenza reciproca) solo per le ipotesi di: a) assoluta novità della questione trattata o b) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Dal 01 gennaio 2016 ad oggi è possibile (oltre che per la soccombenza reciproca) solo per l’ipotesi di sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali che devono essere espressamente motivate.
Si può conclusivamente affermare che il legislatore delegato della riforma (attuata col Dlgs 156/2015) nella regolamentazione della disciplina per la compensazione delle spese nel processo tributario ha scelto un criterio molto più elastico rispetto a quello, molto più ristretto, previsto per il processo civile.
Passando, quindi, all’esame dei possibili casi di compensazione delle spese nel processo tributario va innanzitutto rilevato che in caso di soccombenza reciproca la quantificazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che effettua il bilanciamento tra le posizioni delle parti con riferimento all’esito complessivo della lite.
Sul punto occorre però precisare che, se è pur vero che l’art.10, comma 1, lett.b, n.11 della legge delega n.23/2014 prevede “l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca”, tuttavia è stato autorevolmente ribadito il preesistente principio secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, “sottende…una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. 22381/09- 21684/13 e 19520/2015, nonché Circ. dell’Agenzia delle Entrate n.38/E del 29/12/2015).
Come si è già evidenziato, però, nel processo tributario il caso della soccombenza reciproca ha riferimento, in primo grado, solo al parziale accoglimento della domanda del contribuente, potendo la vera e propria soccombenza reciproca (a carico delle parti contrapposte) verificarsi solo nei successivi gradi di giudizio..
Per quanto invece concerne la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, va innanzitutto rilevato che esse non possono farsi derivare dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle disposizioni che lo regolano ma devono avere riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass.sez. trib. 1091/2016).
Invero, come è stato correttamente ritenuto, la norma che consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni è “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con giudizio censurabile in fase di legittimità” (Cass. 2883/2014 e 591/2017), fermo restando che il vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso innanzi alla Cassazione, è ravvisabile se le ragioni addotte si rivelino illogiche o erronee.
Certamente si ritiene possibile far rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni le ipotesi della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero i casi per i quali l’art.92/2 del c.p.c. prevede la compensazione delle spese di lite, a condizione comunque che, quanto alla mutata giurisprudenza, siano indicate con precisione le sentenze (ovviamente della Cassazione) dalle quali risulti il mutamento giurisprudenziale che abbia comportato il c.d. revirement del giudice. In detto caso, infatti, la compensazione delle spese si giustifica in ragione dell’affidamento fatto dal soccombente che agì o resistette in giudizio confidando sul precedente insegnamento giurisprudenziale già condiviso da giudice e poi venuto meno (Cass.10917/2016 e 1521/2016).
E’ stato invece escluso che l’omessa presentazione della istanza di autotutela da parte del contribuente possa giustificare la compensazione delle spese poiché “l’opportunità di risolvere in via di autotutela le controversie, al fine di evitare il proliferare di contenziosi e di lucrare sulle spese processuali” è illogica ed erronea poiché si risolve in “una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art.24 della Costituzione” (Cass.11222/2016).
Quanto all’ipotesi di annullamento in autotutela dell’atto da parte dell’A.F. nel corso del giudizio si ritiene che la valutazione sulla sussistenza o meno delle gravi ed eccezionali ragioni sia da effettuare caso per caso poiché se è di certo condivisibile che il detto annullamento, in presenza di una oggettiva complessità della materia, possa costituire “un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass.7273/2016), d’altra parte, in presenza di un annullamento che consegua ad una esposizione in sede processuale di tesi diverse da quelle sostenute in sede di accertamento, non potrebbe giammai essere giustificato il premio della compensazione delle spese.
Dovrà pertanto essere valutato il comportamento complessivo tenuto dall’A.F. sia durante il processo che nella precedente fase amministrativa, così escludendosi la possibilità di compensazione delle spese nell’ipotesi che l’A.F. abbia ritardato l’autotutela per avere tenuto un comportamento superficiale rispetto alle osservazioni proposte dal contribuente o abbia comunicato l’annullamento al contribuente solo dopo che lo stesso si sia costituito in giudizio.
Va del pari esclusa la possibilità di compensazione delle spese in caso di omessa costituzione dell’A.F.
Come si è già detto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte che ha dato causa al giudizio rimanga contumace o riconosca come fondata l’avversa pretesa, costituendo un tale comportamento “espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass 373/2015).
C) la responsabilità aggravata e la c.d. lite temeraria
Con l’art.15, comma terzo, del Dlgs 546/92 (inserito dal Dlgs 156/2015 a decorrere dal 01/01/2016) viene disposto un rinvio puro e semplice all’art. 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile, che, sotto il titolo responsabilità aggravata, disciplina due ben distinte ipotesi di condanna del soccombente, ulteriori ed accessorie rispetto alla condanna alle spese di lite, ipotesi che hanno in comune solo la funzione di scoraggiare l’abuso del processo, anche se fino ad oggi sono state incomprensibilmente ed illegittimamente scarsamente applicate.
La prima ipotesi è così testualmente definita dall’art.96/1 del c.p.c. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
Nel terzo comma del cit. art.96 è invece disposto che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche di ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Le due ipotesi sono del tutto diverse ma di certo hanno in comune la ratio che è quella di prevenire, scoraggiando, le c.d. liti temerarie, ovvero le azioni meramente dilatorie o pretestuose che configurano il c.d. abuso del processo. Pertanto per la loro configurabilità non è di certo sufficiente la mera infondatezza della pretesa, essendo invece necessaria la palese infondatezza della stessa, ovvero la totale insostenibilità in punto di fatto oppure la palese illegittimità in punto di diritto, degli argomenti dedotti a sostegno, infondatezza sorretta, come meglio si dirà di seguito, da idoneo elemento psicologico (mala fede o colpa grave).
Prima di esaminare le differenze tra le due ipotesi di responsabilità aggravata è opportuno precisare che con il Dlgs 156/2015, che le ha ufficialmente introdotte nel processo tributario, il legislatore non ha fatto altro che prendere atto del costante ed autorevole indirizzo giurisprudenziale che già in epoca antecedente ne affermava l’applicabilità da parte del giudice tributario.
In proposito si ricorda la pronuncia della Cassazione Sezioni Unite (n.13899/2013) con cui, previo riferimento al generale rinvio al codice di procedura civile contenuto nell’art.1 Dlgs 546/92, si affermò la possibilità per il giudice tributario di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell’esercizio, da parte dell’A.F., di una pretesa impositiva temeraria, perché gravemente negligente ed imprudente, in tal modo sanzionando la manifesta infondatezza della resistenza processuale dell’A.F. non coerente con il principio del giusto processo sancito dall’art.111 Cost.
1) La prima ipotesi responsabilità per lite temeraria
La prima ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria costituisce una vera e propria azione speciale di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. che, in quanto tale, richiede la precisa domanda della parte vittoriosa e l’esistenza dell’elemento psicologico, consistente nell’avere azionato la propria pretesa o resistito a quella avversaria con mala fede o colpa grave, ovvero con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, oppure senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, e comunque “senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. 3376/2016).
Non si richiede, invece, una specifica prova dell’entità dei danni subiti in seguito all’azionamento della palesemente infondata pretesa poiché è testualmente previsto che il giudice possa provvedere alla liquidazione dei danni anche di ufficio con la sentenza. Il giudice, infatti, potrà liquidare in via equitativa il danno non solo materiale (art.2043 c.c.), consistente, tra l’altro, nelle spese che normalmente si sostengono per consultare il commercialista, per le varie trasferte verso l’ufficio dell’A.F., nonché quelle accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la stessa, ma anche il danno esistenziale (art.2059 c.c.), tenendo conto dello stress e patema d’animo subito dal danneggiato, nonché di eventuali altri elementi.
Giova in proposito ricordare l’inveterato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata non è necessario che l’interessato deduca e dimostri uno specifico danno, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza” (Cass. 1031/2001).
2) La seconda ipotesi di responsabilità per lite temeraria
La seconda ipotesi di lite temeraria si atteggia, invece, prevalentemente come sanzione per avere abusato del processo, tanto evincendosi dalla irrilevanza della domanda della parte, potendo il giudice provvedere “in ogni caso” alla liquidazione non già dei danni, bensì di “una somma equitativamente determinata”.
Quanto all’elemento psicologico si ritiene necessaria anche per detta ipotesi la mala fede o colpa grave, essendo incontestabile che anche per le sanzioni si richiede la sussistenza dell’elemento psicologico.
E’ però da escludere che sia sufficiente la colpa lieve, ovvero la mera negligenza o imprudenza, e questo non già perché la colpa lieve non sia sufficiente elemento psicologico di una sanzione ma essenzialmente perché, come si è già detto in precedenza trattando della soccombenza (sub A), agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. 3003/2014) attesa la natura oggettiva della soccombenza e comunque considerando che la colpa lieve, ovvero una mera imprudenza o negligenza nella valutazione dell’oggetto della lite, non potrebbe giammai configurare abuso del processo.
Va rilevato, quanto alla affermata natura sanzionatoria della ipotesi di cui al terzo comma dell’art.96 c.p.c., che con sentenza n.152 del 26/6/2016 della Corte Costituzionale è stata rigettata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze per essere la somma oggetto di sanzione destinata alla controparte invece che allo Stato.
La Corte, dopo avere bene sottolineato la natura di sanzione dell’istituto di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. e la sua funzione volta a scoraggiare l’abuso dei processi assicurandone la ragionevole durata, ha rilevato che la predetta natura sanzionatoria non è contraddetta ma anzi confermata dal fatto che il pagamento della somma è previsto a favore della controparte, essendo ciò connesso con “l’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna”, e tanto sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma “in tempi e con oneri inferiori a quelli che graverebbero su un soggetto pubblico”.
3) La palese insostenibilità della pretesa dell’Amministrazione Finanziaria
E’ stato poi condivisibilmente affermato che la totale insostenibilità della pretesa contenuta nell’atto impositivo e dedotta in giudizio induce a ritenere, ex art 2727 c.c., che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave che sussiste quando si agisca o resista in giudizio “con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criterio e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. sez. VI n.2584/2016).
Proprio seguendo il detto insegnamento le più recenti decisioni della Suprema Corte si sono allineate al “principio secondo cui la palese insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben può costituire fondamento d’una condanna ex art.96 c.p.c. (ex aliis, sez.6-3 Ordinanza n.3376 del 22/2/2016, Rv.638887; sez 5, sentenza n. 15030 del 17/7/2015, Rv.636051; sez.3 sentenza n.4930 del 17/7/2015, Rv.636051; sez.3, Sentenza n.4930 del 12/3/2015, Rv.634773; sez 3, sentenza n.817 del 20/01/2015, Rv.634642)”.
Deve poi essere precisato che il concetto di responsabilità processuale, in cui rientrano entrambe le ipotesi di cui all’art.96 c.p.c. al quale rinvia l’art.15 cit., va inteso in senso estensivo “comprensivo, cioè, anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti (mala fede o colpa grave) ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto” ( Cass.13899/2013) e che la domanda con cui si chiede il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., “può essere proposta per la prima volta in fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. La ragione è che una tale domanda non è soggetta al regime delle preclusioni di cui all’art.345, primo comma, c.p.c., tutelando un diritto che, per essere conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all’agire o al resistere in giudizio. E, come tale, non è esercitatile in via di azione autonoma” (Cass.1115/2016).
4) Il rifiuto di annullamento e la responsabilità aggravata
E’ da ritenere che la prova della responsabilità processuale, con specifico riguardo all’elemento psicologico ed alla conseguente presunzione di cui si è detto, sia assolutamente incontestabile nell’ipotesi di silenzio o rifiuto sull’istanza di annullamento in autotutela di atto poi giudicato illegittimo perché palesemente contrastante con la legge.
Come è ben noto con la richiesta di esercizio dell’annullamento in autotutela il contribuente chiede all’A.F. di riesaminare un atto che ritiene illegittimo.
Orbene si ricorda che con l’art.2 quater del D.L. 564/1994 fu disposto che con decreti del MEF fossero indicati gli organi dell’Amministrazione Finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati. Fu inoltre disposto che “Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’amministrazione”.
Con il successivo decreto n. 37/1997 del Ministro delle Finanze (artt. 7 e 8) furono definiti i “criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa”, indicandosi tra l’altro “la giurisprudenza consolidata nella materia, il criterio di probabilità di soccombenza e della conseguente condanna dell’Amministrazione finanziaria di rimborso delle spese di giudizio…l’esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse”.
Con la Circolare n. 198/1998 del MEF (Uff. Coscienza Civica Serv. Di Coordinamento) fu rilevato che “…è indubbio che l’ufficio stesso non possiede un potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori. Infatti da un lato il mancato esercizio dell’autotutela nei confronti di un atto patentemente illegittimo, nei casi in cui sia ancora aperto o esperibile il giudizio, può portare alla condanna alle spese dell’amministrazione con conseguente danno erariale (la cui responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sul dirigente e responsabile del mancato annullamento dell’atto); dall’altro… è evidente che l’esercizio corretto e tempestivo viene considerato dall’amministrazione non certo come una specie di optional che si può attivare o non attivare a propria discrezione, ma come una componente del corretto comportamento dei dirigenti degli uffici e quindi come un elemento di valutazione della loro attività dal punto di vista disciplinare e professionale”.
Circa tre anni dopo, con la Circolare MEF n.22/E del 26 maggio 2011, veniva previsto che prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado fosse valutato, previo esame dei motivi di ricorso, il grado o rating di sostenibilità della controversia, al fine di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per l’autotutela o per la conciliazione giudiziale, totale o parziale. Era espressamente disposto che “va esercitata l’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio”.
Nello stesso mese di maggio 2011 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate (dr. Befera) inviava una lettera con cui invitava tutti i dipendenti ad operare con correttezza ed efficienza richiamandoli alle proprie responsabilità e ricordando che l’azione di controllo si rivela efficace solo se corretta e non quando esprime arroganza e sopruso o comunque comportamento non ammissibile nell’ottica di una corretta e civile dialettica, ribadendo le conseguenze non solo disciplinari, ma anche risarcitorie del comportamento arrogante o negligente di essi dipendenti.
Con la successiva Direttiva n.48/2012 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale degli Affari Legali, rammentava ai funzionari delle sedi dipendenti che il tempestivo intervento finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo, mediante lo strumento dell’autotutela, consente di limitare i costi del contenzioso, riduce il rischio di soccombenza e condanna alle spese di lite ed evita, conseguentemente, la responsabilità diretta del funzionario titolare del procedimento.
Infine con la nota n.21516/2012 Il Direttore dell’A.E. rammentava agli uffici periferici che l’utilizzo dell’autotutela non corrisponde ad una mera facoltà residuale del funzionario amministrativo, ma ad un dovere della P.A., dovere a cui sono collegate precise responsabilità e un metodo con cui attuare i principi di civiltà giuridica contenuti nell’ordinamento tributario mediante la rimozione degli atti illegittimi al fine di migliorare i rapporti di tax compliance con i contribuenti.
Sul rapporto tra l’esercizio dell’autotutela e la responsabilità della A.F. si pronunciava anche il Giudice di legittimità che riconosceva la risarcibilità “del danno sopportato da un soggetto per ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l’atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che si riferiscono ad un procedimento amministrativo…il danno di cui si chiede il risarcimento in realtà deriva dal compimento dell’atto illegittimo…essendo l’intervento in autotutela solo il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto da costringere il privato ad affrontare spese pegali e di altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile” (Cass. 698/2010).
Più in generale è stato ritenuto che “l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem ledere, codificato dall’art.2043 c.c…. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art.97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art.2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale” (Cass. 5120/2011).
Consegue che, nell’ipotesi di omesso esercizio dell’annullamento in autotutela richiesto specificamente dal contribuente, il giudice che annulli l’atto impositivo perché palesemente infondato nel merito o palesemente illegittimo, in nessun caso potrà esimersi dal condannare l’A.F. per responsabilità aggravata ex art. 15 Dlgs 546/92.
E’ opportuno rilevare sul punto che il funzionario dell’A.F. (in genere il Direttore dell’Agenzia fiscale o il funzionario delegato) che abbia emesso l’atto impositivo ritenuto palesemente illegittimo non potrà esimersi da responsabilità patrimoniale (verso l’erario o anche verso il contribuente) e disciplinare deducendo di avere ottemperato ad un ordine del superiore gerarchico, anche se contenuto in una disposizione avente carattere generale (Direttiva o Risoluzione) se la disposizione stessa sia ritenuta palesemente illegittima, a meno che non provi di avere ottemperato al c.d. dovere di rimostranza.
Dispone infatti l’art.17 del DPR n.3/1957 (T.U. impiegati civili dello Stato) rubricato “Limiti al dovere verso il superiore” che l’impiegato al quale venga impartito un ordine ritenuto palesemente illegittimo ha l’obbligo – in deroga al dovere di “eseguire gli ordini che gli siano impartiti relativamente alle proprie funzioni o mansioni” imposto dall’art.16, primo comma, del detto T.U.- di farne rimostranza al proprio superiore, dichiarandone le ragioni.
Dal testuale disposto del cit. art. 17 risulta che “Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione” a meno che “l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Pertanto l’omesso esercizio della rimostranza, comportando l’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 18, secondo comma, T.U. cit., configura colpa dell’impiegato, rilevante ai fini della responsabilità patrimoniale sia verso lo Stato che verso il contribuente (artt. 18, I comma, e 22 T.U. cit.).
Come bene rilevò il Consiglio di Stato “Non sussiste dunque un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il c.d. dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto. Qualora ricorra un’evenienza del genere, il pubblico impiegato ha tuttavia l’obbligo di fare una immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l’ordine e se quest’ultimo è ribadito per iscritto, allora il dipendente non può esimersi dall’eseguirlo, a meno che l’esecuzione configuri un’ipotesi di reato” (Cons. Stato. Sent. n.6208/2008).
D) la liquidazione delle spese del giudizio
I commi 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies dell’art.15 Dlgs 546/92 contengono disposizioni sulla liquidazione delle spese del giudizio.
Prima di esaminare le varie voci delle spese di lite ed i criteri ai quali deve attenersi il giudice è bene premettere che, ai sensi dell’art.15, I comma, cit., le spese predette “sono liquidate con la sentenza” mentre, ai sensi del comma 2 quater della stessa norma, le spese della fase cautelare sono liquidate con l’ordinanza che decide sulla relativa istanza.
La differenza non è di poco conto poiché mentre le spese relative alla fase cautelare possono essere modificate con la sentenza e non sono provvisoriamente riscuotibili, come meglio si dirà di seguito, invece per quelle liquidate con la sentenza l’art.69, I comma, Dlgs 546/92, non ponendo alcuna differenziazione tra le somme da corrispondere per effetto della condanna e le spese del giudizio relativo, ne prevede la immediata riscuotibilità se liquidate in favore del contribuente.
Tuttavia la provvisoria esecutività della sentenza relativamente alle spese (per le altre somme, se superiori ad € 10.000, vi è la condizione della eventuale – può essere - subordinazione a garanzia da determinare in conformità a quanto disposto dal DM n.22/2017 di cui si è detto in precedenza) prevista solo in favore del contribuente suscita, come in precedenza già rilevato, qualche perplessità con riferimento alla contraria ipotesi prevista per le spese liquidate a favore dell’A.F. per le quali, come dispone l’art.15, comma 2 sexies, ultima parte, del Dlgs 546/92, “La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Fatta tale premessa giova precisare che il giudice ha il dovere di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio anche in assenza di una domanda della parte vittoriosa poiché trattasi di pronuncia accessoria e consequenziale a quella che decide sulla soccombenza definendo il grado del processo.
L’indicazione delle voci che compongono le spese del giudizio è contenuta nel comma 2 ter dell’art.15 che così dispone: “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
1) La liquidazione del contributo unificato
Quanto al contributo unificato, che è anticipato dal contribuente (o dalla parte che impugna la sentenza), in caso di compensazione delle spese dovrà essere indicata la parte a carico della quale esso è posto e che sarà quella maggiormente soccombente o, in caso di compensazione totale, entrambe le parti in misura paritaria.
Quanto al valore della causa, che costituisce il parametro in base al quale determinare l’entità del contributo unificato da corrispondere, l’art.1, comma 598 lett.a) della Legge n.147/2013, dispone espressamente che il valore della causa deve essere determinato in base all’art.12, comma 2, Dlgs 546/92, ovvero in base all’ “importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
La misura del contributo unificato tributario (c.d. CUT) è stabilita secondo vari scaglioni, rapportati al valore della causa come sopra determinato, dall’art.13, comma 6 quater, del DPR 115/2002 (TUSG).
Giuseppe Di Nardo
Giuseppe Di Nardo