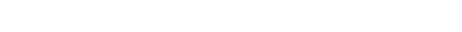I documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria
Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
I DOCUMENTI DI PRASSI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
(Aggiornamento Aprile 2017)
1) Premessa
Dalla fine dell’anno 2014 in poi varie Commissioni Tributarie hanno dovuto occuparsi dei ricorsi, proposti da alcuni giudici tributari, aventi ad oggetto il rifiuto del Ministero delle Finanze avverso richieste di rimborso per omessa applicazione dell’aliquota separata su compensi arretrati maturati nell’ultimo trimestre dell’anno precedente ma corrisposti dopo la data del 12 gennaio dell’anno successivo. I ricorsi, con una sola eccezione, sono stati tutti accolti in primo grado rilevandosi che il rifiuto dell’A.F. era fondato su una Direttiva del MEF (la n.5/2014 del 12 dicembre 2014) palesemente contrastante con il preciso disposto della legge (artt.51 e 17 DPR 917/1986).
Prima di trattare, in generale, del valore giuridico dei documenti di prassi della P.A. e del dovere di obbedienza e connessa responsabilità dei funzionari amministrativi, che ne sono i destinatari, nonché della A.F. nei confronti dei contribuenti, si ritiene opportuna, per evidenti motivi di chiarezza, una esposizione dei fatti e dei motivi di diritto che hanno indotto le Commissioni Tributarie ad accogliere i ricorsi proposti avverso il diniego di rimborso.
2) Il principio di cassa e la cassa allargata
Ai sensi dell’art. 50, I comma lett.f, DPR 917/86 (TUIR) il reddito costituito dai compensi corrisposti ai giudici delle Commissioni Tributarie è assimilato a quello corrisposto ai prestatori di lavoro dipendente che, ai sensi dell’art. 51, I comma prima parte TUIR, “è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Nel diritto tributario vige il c.d. principio di cassa in base al quale ai fini del prelievo fiscale per qualsivoglia erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro deve aversi riguardo al momento della percezione, e non già dell’erogazione (v. Cass. sez.trib. 5575/2011).
L’art. 51, I comma seconda parte, del TUIR pone poi il c.d. principio di cassa allargata in base al quale “Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
La c.d. cassa allargata costituisce una sorta di fictio juris (le somme percepite dal lavoratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla percezione subiscono il medesimo trattamento fiscale di quelle corrisposte nell’anno precedente) che trova la propria giustificazione nella necessità di concedere al datore di lavoro un termine per effettuare i conteggi del caso per le somme da corrispondere al lavoratore per l’attività prestata nell’anno precedente.
Il predetto termine del 12 gennaio ha natura perentoria non solo perché indicato con precisione dalla legge ma perché così ritenuto sia dalla giurisprudenza (v. Cass. sez. trib. 2854/12) che dalla stessa Agenzia delle Entrate secondo la quale “Con riferimento alla data del 12 gennaio… non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’art.2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo” (v. Circolare A.E. del 15 gennaio 2003 n.2 par.8).
3) La tassazione separata
L’art.17, comma 1 lett.b, TUIR dispone che l’imposta si applica separatamente per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma I dell’art.47 (ora 50)”, ovvero compresi, tra gli altri, i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie (ex art.50 lett.f).
La tassazione separata, applicabile ai compensi percepiti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, costituisce un’agevolazione fiscale poiché consente di applicare ai compensi predetti una tassazione con aliquota inferiore a quella massima applicabile in via ordinaria.
Infatti, ai sensi dell’art.21 TUIR, con la tassazione separata l’imposta è determinata applicando alla somma totale percepita come arretrato l’aliquota corrispondente percentualmente a quella applicabile alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito da tassare separatamente. Il calcolo si effettua dividendo per due la somma dei redditi dei due anni precedenti a quello in cui è maturato il reddito da tassare e quindi determinando sul totale l’IRPEF secondo le aliquote vigenti. Successivamente si calcola la percentuale di IRPEF applicabile alla somma da sottoporre a tassazione separata effettuando la proporzione con l’importo di IRPEF calcolato come applicabile al reddito medio predetto (es.: media del reddito del biennio precedente = A; imposta ordinaria applicabile ad A = B; calcolo dell’aliquota media: A:B= 100:X; X = Bx100:A).
La ratio evidente della tassazione separata è quella di evitare che, per la concomitanza del c.d. principio di cassa stretto con quello della progressività dell’ IRPEF, il contribuente subisca una tassazione più elevata per il cumulo dei proventi dell’anno con quelli arretrati.
Un aspetto importante della tassazione separata (per quello che rileva ai fini della presente nota che concerne i documenti di prassi della P.A.) è da ravvisare nel fatto che, secondo il preciso disposto dell’art.17 cit., le uniche cause di esclusione della tassazione separata sono quelle che dipendono dalla volontà delle parti (ovvero dalla volontà collusiva del datore di lavoro e del lavoratore che concordino di ritardare oltre il 12 gennaio la corresponsione degli arretrati affinché il secondo goda della tassazione separata), restando pertanto esclusa ogni qualsivoglia altra causa, compreso il ritardo burocratico per la corresponsione degli arretrati.
Sulla irrilevanza di qualsivoglia altra causa, con l’unica eccezione prevista dalla legge e di cui si è detto, per l’esclusione della tassazione separata degli arretrati si pronunciava anche il Giudice di legittimità che testualmente affermava che il legislatore “…attribuendo rilevanza ad altre cause ha certamente inteso allargare la fattispecie degli emolumenti arretrati…relativi ad anni precedenti assoggettabili a tassazione separata; lo stesso però, con evidente intento antielusivo, richiedendo che tali altre cause non siano dipendenti dalla volontà delle parti ha tolto qualsiasi efficacia ad eventuali…accordi datore e prestatore di lavoro, ovvero ad aderenti comportamenti di tali parti tesi a procrastinare la erogazione (percezione di qualche emolumento in anni successivi) al fine di consentire al dipendente di beneficiare comunque del minor carico fiscale quale emolumento relativo ad anni precedenti” (Cass. 19606/2005).
4) La Circolare n. 23/97 del MEF e il c.d. ritardo fisiologico
Nonostante l’inequivocabile chiarezza della lettera e della ratio dell’art.17 TUIR il MEF, Direzione della Giustizia Tributaria, con la Circolare n.23/97 (Entrate Aff.Giuridici Serv. III), contestava la perentorietà del predetto termine del 12 gennaio affermando che, relativamente ai compensi arretrati corrisposti ai giudici tributari, esso era dilatabile fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
La tesi del MEF era giustificata dando rilievo al ritardo burocratico necessario per effettuare i conteggi delle somme dovute, ritardo che definiva fisiologico, in tal modo ignorando che il legislatore aveva esso stesso fissato il ritardo fisiologico, determinandolo nel termine perentorio di giorni dodici, ovvero del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei compensi.
La palesemente illegittima tesi del MEF era però contrastata, oltre che dalla Cassazione (come sopra precisato) anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, con la Risoluzione n.3 del 17/02/2004 (a firma del Presidente Ennio Attilio Sepe), confermata dalla Delibera n.530/2011 (a firma del Presidente Daniela Gobbi), chiariva che le questioni relative ai tempi tecnici necessari per procedere, in concreto, alla determinazione e liquidazione dei compensi variabili per i giudici tributari “sono rilevanti al fine di definire l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per ritardato pagamento (interessi e svalutazione) non ai fini di applicare la disciplina propria della tassazione separata che si fonda sul dato obbiettivo del mancato pagamento entro il 12 gennaio dell’anno successivo ed ha lo scopo di evitare le sperequazioni impositive che potrebbero derivare dall’applicazione del principio di cassa nel computo dei redditi”.
5) L’art.39, comma 5, D.L. n.98/2011 (conv. in L. n.111/2011)
Gli autorevoli chiarimenti resi dal CPGT e dal Giudice di legittimità in ordine alla irrilevanza del ritardo burocratico per la corresponsione degli emolumenti arretrati ai fini della esclusione della tassazione separata inducevano il MEF ad attivarsi, approfittando del particolare momento politico (era l’epoca del Governo Monti), per ottenere dal Parlamento l’approvazione di una legge che recepisse quanto affermato dalla Circolare n.23/97, ovvero l’esclusione della tassazione separata per i compensi arretrati corrisposti ai giudici tributari.
Veniva così disposto, con l’art.39, comma 5, del D.L. n.98/2011 (conv. con mod. in L.111/2011 contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) che “i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’artt. 11 del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917”.
Avverso la predetta disposizione legislativa la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con Ordinanza in data 11 novembre 2013 (relatore ed estensore il presidente Di Nardo) sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 53 e 104 della Costituzione.
Veniva precisato, nella ordinanza predetta, che era stato violato il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, di cui all’art.3 Cost., poiché “fra tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art.50 TUIR, solo per gli emolumenti arretrati per prestazioni riferibili all’anno precedente corrisposti ai giudici tributari l’art.39/5 cit. ha previsto, a decorrere dal 17/7/2011 la tassazione ordinaria…se corrisposti entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento”.
La violazione dell’art.53 Cost. (capacità contributiva e criterio di progressività del sistema tributario) era ravvisabile nel fatto che, pur essendo vero che il legislatore si era trovato “nella necessità di rispettare le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica…l’intervento sui meccanismi retributivi dei giudici tributari avrebbe dovuto essere adottato in un sistema di coinvolgimento di tutti i contribuenti, o quanto meno di tutte le categorie di cui all’art.50/I TUIR, secondo i principi di pari capacità contributiva e progressività, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza e non attraverso una manovra irrazionale e discriminatoria”.
La violazione dell’art.104 Cost (principio di autonomia e indipendenza dei giudici) era ravvisabile nella manifestazione, con la disposizione censurata, di “una sorta di supremazia del potere esecutivo, ed anzi più specificamente del MEF, che ha predisposto il DL 98/2011 e che, per di più, è debitore, nei confronti dei giudici tributari per i compensi, già abbastanza esigui, da corrispondere agli stessi (nonostante che esso MEF rivesta, inconcepibilmente, la qualità di parte sostanziale, attraverso le Agenzie fiscali, nella maggior parte dei giudizi tributari) sul potere giudiziario”.
Con sentenza n.142/2014 del 04/6/2014 la Corte Costituzionale accoglieva la proposta eccezione e dichiarava l’illegittimità costituzionale del cit. art.39, comma 5, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Nella sentenza della Consulta veniva tra l’altro precisato che “la ratio dell’istituto in esame (ovvero della tassazione separata, n.d.r.) è quella di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell’IRPEF…si giustifica proprio nella misura in cui costituisce per il contribuente un rimedio per evitare una applicazione ingiustificatamente gravosa del principio di cassa…la norma impugnata ha vanificato l’effetto mitigatore e correttivo del regime della tassazione per cassa…la finalità di limitare in qualche modo gli effetti delle modalità temporali di liquidazione…viene nella sostanza neutralizzata dalla introduzione di una disposizione idonea a rendere ininfluenti, a danno del contribuente, anche tempi tecnici anomali come quelli che raggiungono la durata di un anno”.
6) La Direttiva MEF n. 5/2014
Nonostante il chiaro disposto degli artt. 51 e 17 TUIR, le autorevoli interpretazioni delle citate disposizioni fornite dalla Cassazione nella sentenza n.19606/2005 e nelle due Delibere del CPGT (n.3/2004 e 530/2011) e la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art.39/5, con un’arroganza e tenacia a dir poco riprovevoli e, comunque, contrastanti con i principi di legalità, buona amministrazione e buona fede ai quali (secondo l’art.97 della Costituzione, l’art.1 L. 241/90 e gli artt.1 e 10 della Legge 212/2000 c.d. Statuto del Contribuente) deve essere sempre improntata l’azione della Pubblica Amministrazione, con la Direttiva n. 5/2014 ( a firma F. Sirianni) in data 12 dicembre 2014 il MEF disponeva che “…per quanto riguarda gli emolumenti variabili (dei giudici tributari n.d.r.) relativi al quarto trimestre, tenuto conto che il loro pagamento avviene normalmente dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, la tassazione da applicare non potrà essere che quella ordinaria sempre che la liquidazione avvenga entro il 31 dicembre di tale anno”.
In tal modo, ovvero dilatando fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento il principio di cassa per gli arretrati da corrispondere ai giudici tributari, e così escludendo la tassazione separata, la Direttiva n.5/14 veniva a porsi in contrasto con il testuale disposto dell’art.17 TUIR cit che, una volta eliminato dal mondo giuridico l’art.39/5 DL 98/2011 (per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale) era da ritenere pienamente vigente anche per i giudici tributari.
Non sembra superfluo, anche se ripetitivo, ricordare che dal testuale disposto dell’art.17 TUIR risulta che l’unica oggettiva situazione di fatto che giustifica il ritardo nel pagamento degli arretrati dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, con conseguente applicazione del criterio di cassa (allargato), è esclusivamente quella che la legge stessa indica, ovvero la concorde volontà collusiva delle parti: i compensi che per qualsivoglia altra causa, incluso il ritardo burocratico per consentire i conteggi, siano corrisposti successivamente alla predetta data del 12 gennaio devono ritenersi corrisposti con ritardo patologico e pertanto devono godere del regime fiscale agevolato della tassazione separata.
Né può omettersi di rilevare che la declaratoria di incostituzionalità dell’art.39/5 cit. ha investito la disposizione, ovvero la previsione di applicabilità del principio di cassa per gli arretrati dei giudici tributari corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza, nella sua integralità e non limitatamente ai soli primi tre trimestri come dispone la Direttiva n.5/14.
7) Le sentenze di merito e la Direttiva MEF n.5/2014
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art.39, comma 5, vari giudici tributari proponevano tempestive istanze di rimborso al MEF per ottenere la restituzione della differenza tra la maggiore imposta IRPEF trattenuta in applicazione dell’aliquota ordinaria e quella minore dovuta in applicazione della tassazione separata sui compensi relativi agli ultimi trimestri degli anni di maturazione e corrisposti successivamente al 12 gennaio dell’anno successivo.
Le istanze erano tutte rigettate dal MEF in ossequio alla Direttiva n.5/2014.
In qualche caso veniva anche chiesto al MEF di provvedere all’annullamento in autotutela del rigetto, ma anche detta istanza era rigettata per lo stesso motivo.
In un caso, in particolare, era anche richiesto l’intervento del Garante del Contribuente, intervento che, per quanto autorevole, non sortiva alcun effetto poiché il competente Ufficio dell’A.E. comunicava che il diniego derivava “soprattutto da indicazioni degli Organi centrali”, con più che evidente riferimento alla nota Direttiva MEF n.5/2014.
Venivano quindi proposti i ricorsi avverso i vari provvedimenti di rifiuto delle istanze di rimborso, ricorsi che, attesi gli importi (poche centinaia di euro), producevano anche gli effetti di reclamo, ex art.17 bis Dlgs 546/92, reclamo che, tuttavia, non era accolto dall’A.E. che si premurava di ricordare (nel provvedimento di rigetto) che avrebbe difeso “gli interessi erariali in ogni stato e grado del giudizio”.
Nei vari ricorsi veniva evidenziata la palese illegittimità del rifiuto di rimborso atteso il chiaro disposto degli artt.51 e 17 TUIR e la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 39/5 cit. dalla quale era conseguito il ripristino della normativa del TUIR anche per i giudici tributari.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva e controdeduceva indicando i suoi documenti di prassi, e segnatamente la famosa Direttiva n.5/2014 nonché un passaggio dell’esposizione contenuta nella sentenza della Consulta in cui era indicata l’interpretazione data dal MEF all’art.17 TUIR, interpretazione che, secondo l’A.E., doveva ritenersi essere stata recepita dalla Consulta.
Premesso che fino ad oggi non risulta ancora emessa alcuna sentenza dal Giudice di legittimità sui ricorsi proposti, sono di seguito indicate le sentenze emesse da varie Commissioni Tributarie che concordemente, con la sola eccezione di quella di Macerata, hanno accolto i ricorsi proposti dai giudici tributari.
La prima sentenza, in ordine cronologico, ha ad oggetto un ricorso proposto dallo scrivente (all’epoca presidente della CTP di Campobasso) avverso il rifiuto di rimborso della differenza di IRPEF sul compenso aggiuntivo dell’ultimo trimestre dell’anno 2011 (corrisposto dopo il 12 gennaio 2012) per l’espletata attività di giudice tributario.
Il ricorso veniva accolto con la sentenza n.163/1/14 emessa dalla CTP di Isernia in data 04/6/2014 (dep. il 02/7/2014).
La sentenza non appare rilevante in punto di motivazione, poiché si limita a riconoscere il diritto al rimborso per effetto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art.39/5 DL 98/2011, ma rileva per altro effetto.
La predetta sentenza, infatti, fu emessa circa sei mesi prima che, nel dicembre dell’anno 2014, fosse emanata la famosa Direttiva n. 5/2014 e passò in giudicato per omessa impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che provvide a rimborsare la differenza IRPEF trattenuta in eccesso sui compensi arretrati.
Solo dopo l’emissione della Direttiva n.5/2014, ovvero dal dicembre 2014, l’A.E., ottemperando alla stessa, iniziò ad effettuare contestazioni sulla applicabilità della tassazione separata agli emolumenti corrisposti ai giudici tributari dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.
La predetta sentenza della CTP di Isernia costituisce pertanto la prova documentale che, secondo il convincimento (abnorme) dell’A.E., i provvedimenti di prassi della Pubblica Amministrazione (nella specie la Direttiva cit.) dovrebbero sempre avere prevalenza sulle norme di legge (artt.17 e 51 TUIR) e sulle decisioni della Corte Costituzionale (sentenza n.142/2014).
Seguono due sentenze emesse dalla CTP di Macerata la quale è l’unica, in tutto il territorio italiano, che immotivatamente, o comunque con motivazione chiaramente contrastante con la legge, condivide, come si dirà di seguito, la tesi dell’A.E. fondata sulla Direttiva n.5 MEF cit.
Con la prima sentenza, recante il n.446/2/2014 (emessa il 25/9/2014), veniva accolta la tesi dell’A.E., secondo quanto si legge testualmente nella sentenza, “alla luce di quanto precede”, ovvero secondo quanto risulta nella parte (integralmente ricopiata) della sentenza della Consulta nella quale è indicata, solo a fini espositivi, la tesi prospettata dall’Agenzia delle Entrate, tesi che però la Consulta evidenzia palesemente di non condividere con la dichiarazione di illegittimità dell’art.39/5 cit. nella sua integralità ( e non per i soli primi tre trimestri dell’anno).
Nella seconda sentenza, ovvero la n.162/2/15, la CTP di Macerata accoglieva la tesi dell’A.E. con la seguente testuale motivazione:”Il pagamento dei compensi variabili in questione, che richiede un determinato periodo di tempo per essere liquidati, rapportandosi al numero e alla tipologia dei provvedimenti emessi, è una conseguenza fisiologica insita nelle modalità di erogazione degli emolumenti stessi ai quali non è quindi applicabile l’invocato regime della tassazione separata”.
Ebbene, anche a volere ignorare l’evidente improprietà della forma espositiva (il soggetto del periodo dovrebbe essere non già il pagamento dei compensi, bensì il ritardo nel pagamento dei compensi), è del tutto evidente che l’affermazione predetta contrasta palesemente con l’art.17, comma 1 lett.b, TUIR che, come si è già detto, ritiene del tutto irrilevante il ritardo fisiologico (rectius:burocratico) nel pagamento degli arretrati, escludendo l’applicabilità della tassazione separata solo per le cause concordate tra le parti ( contribuente ed A.F.).
Le due predette sentenze della CTP di Macerata, pertanto, rilevano solo per dimostrare che la tesi dell’A.F. può essere accolta solo a condizione che si condividano gli illegittimi atti di prassi della stessa.
Tutte le successive sentenze sono concordi invece nell’affermare la palese illegittimità della Direttiva n.5/2014 cit.
Con la sentenza n.1528/15 emessa in data 25/3/2015 (dep. il 15/4/2015) la Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la sentenza appellata, rilevava che il primo giudice “ha accolto il ricorso sostenendo che dalla lettura delle norme il legislatore considera emolumenti arretrati tutti quelli relativi ad anni precedenti erogati in anni successivi sia per effetto di leggi… sia per altre cause non indicate, le quali non debbono essere dipendenti dalla volontà delle parti. Sicchè il legislatore attribuendo rilevanza ad altre cause ha inteso allargare e non restringere la fattispecie degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”.
Nella sentenza veniva rilevato che già con precedenti sentenze, rese tra le stesse parti e passate in giudicato, era stata decisa la medesima questione di diritto in senso favorevole al contribuente, onde la preclusione di ogni contraria decisione.
Vi è poi la sentenza n.1131/3/2015 (emessa il 15/12/2015 e dep. il 16/12/2015) della CTP di Campobasso con la quale veniva innanzitutto risolta, in senso negativo, la questione (posta di ufficio) relativa ad eventuale sussistenza di causa di incompatibilità del collegio giudicante trattandosi di problematica interessante comunque i giudici tributari.
La questione era risolta in senso negativo dandosi atto nella specie della sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità di diritto e non di fatto, con conseguente impossibilità di ravvisare un motivo di astensione, essendo la disciplina sull’astensione posta per i fatti interessanti singoli magistrati e non intere categorie di giudici (Cass. S.U. 12345/2000 e 12525/2003).
Quindi il giudicante, dopo avere chiarito il significato dei principi del criterio di cassa, della cassa allargata e della tassazione separata, rilevava che, secondo il testuale disposto della legge e come ritenuto dalle autorevoli interpretazioni della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, non era in alcun modo rilevante il ritardo burocratico (oltre il termine del 12 gennaio imposto dall’art.51 TUIR) per la liquidazione dei compensi arretrati dei giudici tributari al fine di escludere la tassazione separata, onde la palese illegittimità della c.d. Direttiva Sirianni (n.5/2014) che dispone in senso contrario, sia pure limitatamente ai compensi dell’ultimo trimestre dell’anno.
Con riferimento alla affermazione dell’Agenzia delle Entrate (contenuta nell’atto di controdeduzioni al ricorso) secondo la quale “Dalla pronuncia della Consulta discende dunque…in linea con la prassi richiamata, che sia necessario verificare in concreto le cause del ritardo; ove tale ritardo sia imputabile ai tempi fisiologici richiesti dalle modalità di determinazione ed erogazione degli emolumenti, si deve comunque ritenere applicabile il regime di tassazione ordinaria”, il giudicante faceva rilevare che “nella sentenza della Consulta n.142/2014 la Corte si limita a riportare l’opinione dell’A.F. circa l’assoggettamento dei compensi arretrati dei giudici tributari alla tassazione separata, ma in nessuna parte della sentenza stessa la fa propria o dichiara di condividerla”.
Osservava quindi che, una volta eliminato dal mondo giuridico l’art.39/5 cit per effetto della sentenza della Consulta, la citata Direttiva Sirianni era da ritenere palesemente illegittima perché contrastante oltre che con l’art.17 TUIR anche con la predetta sentenza della Corte Costituzionale della quale aveva ritenuto limitare gli effetti ai soli primi tre trimestri dell’anno precedente a quello della corresponsione degli arretrati.
Segue la sentenza della CTP di Pavia n.164/2016 (emessa il 07/3/2016 e dep. 23/3/2016) con cui veniva accolto il ricorso del contribuente rilevandosi: 1) che la tesi dell’A.F. che pretende di introdurre il concetto di ritardo fisiologico fino a ricomprendervi tutto l’anno di imposta successivo a quello di maturazione dei compensi vanifica il dictum della Consulta poiché tenta di introdurre in via di prassi gli stessi effetti della disciplina dichiarata incostituzionale; 2) che è illegittima l’introduzione, mediante un provvedimento amministrativo, del concetto di ritardo fisiologico dilatato fino all’anno successivo; 3) che, con palese violazione del principio di uguaglianza, viene illegittimamente introdotto, solo per i giudici tributari e mediante provvedimenti amministrativi una disciplina in contrasto con l’art.51 TUIR che circoscrive il ritardo fisiologico entro la data del 12 gennaio dell’anno successivo.
Vi è poi la sentenza n. 1732/2016 della CTP di Lecce (dep. 13/7/2016) nella quale, in accoglimento del ricorso del contribuente, è testualmente affermato che “Il carattere di fisiologicità, dedotto dall’Amministrazione Finanziaria, inerente ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti dovuti…non può rivestire carattere giuridicamente rilevante ai fini della non applicazione dell’aliquota media di tassazione…sussiste regime di tassazione separata ex art.17 DPR 917 del 1986, ed in aggiunta a ciò il ritardo nei versamenti non è attribuibile alla condotta colpevole del…” e quindi, con più precisione, “Il legislatore, facendo ricadere tutti i compensi indicati dall’art.17, comma 1 lett.b, del TUIR nel regime di tassazione separata, non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo, non attribuendo quindi al ritardo fisiologico della P.A. nel corrispondere gli emolumenti, natura di causa di esclusione del regime di tassazione separata”, regime nel quale, soggiunge, devono ritenersi incluse “tutte le altre cause indipendenti dalla volontà delle parti”.
Per ultime si indicano le sentenze n. 91/1/2016 (emessa il 04/5/2016 e dep. il 05/5/2016 ) e n.129/1/2016 (emessa il 29/6/2016 e dep. il 05/7/2016) dalla CTP di Isernia con le quali il Giudicante, in accoglimento dei ricorsi dei contribuenti, dopo avere chiarito che la Consulta, contrariamente a quanto affermato dalla A.F., si limitò a riportare la tesi della stessa solo per illustrarne le ragioni, senza in alcun modo dichiarare di condividerla, precisa che “la tassazione ordinaria conseguiva unicamente all’applicazione della norma dichiarata incostituzionale, sicchè una volta venuta meno tale disposizione non può che riespandersi il principio generale…il ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, in quanto derivante da un fattore oggettivo (criterio di calcolo) di per se avente fondamento normativo e sicuramente non rimesso alla volontà delle parti, rientra appieno nella previsione dell’art.17 TUIR…la suddetta norma non contiene alcun riferimento all’impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento entro il termine del 12 gennaio, quale condizione ostativa alla tassazione separata, sicchè l’interpretazione proposta nella Direttiva n.5/14 del MEF non può essere condivisa”.
8) Valore giuridico ed efficacia dei c.d. Atti di Prassi della Pubblica Amministrazione
Prima di trattare dei c.d. atti di prassi della P.A. è opportuna una precisazione relativa, in modo particolare, alla natura ed agli effetti degli atti tributari.
Ai sensi dell’art.23 della Costituzione nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge dello Stato.
Dal detto principio consegue che solo la legge, e giammai un atto amministrativo (quali le Circolari, Direttive o Risoluzioni del MEF) può imporre un tributo o comunque determinare aliquote o basi imponibili che accrescano il peso fiscale per il contribuente.
E’ opportuno ricordare che, come disposto dall’art.5 della Legge n.2248 del 20 marzo 1865, All. E (Abolizione del contenzioso amministrativo), “Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.
Il principio predetto è pacificamente affermato in varie sentenze della Corte Costituzionale (sent. 204/04- 281/04 e 191/06) la quale, inoltre, proprio in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.39/5 del D.L. 98/2011, di cui si è detto in precedenza, ha ribadito che l’evidente fine di incrementare il gettito di imposta non può rendere costituzionalmente legittime le norme di legge che violino, come il cit. art.39, comma 5, principi costituzionali.
Invero l’attività della Pubblica Amministrazione si deve svolgere nel rispetto della legge e dei regolamenti e si esplica mediante l’emanazione di atti e provvedimenti che sono espressione della potestà amministrativa per la cura concreta di interessi pubblici con effetti diretti verso singoli soggetti o anche verso una pluralità di destinatari determinati o anche solo determinabili.
I provvedimenti amministrativi generali devono essere ben distinti dai regolamenti i quali pur essendo atti soggettivamente amministrativi, in quanto emanati da organi del potere esecutivo, “sono espressione di una potestà normativa attribuita all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell’astrattezza” (Cass. S.U. 10124/1994).
Del tutto diversi, per la natura e per gli effetti, dai regolamenti e dai provvedimenti della P.A. sono i c.d. documenti di prassi (Circolari, Direttive e Risoluzioni) che non hanno né carattere né efficacia normativa, in quanto privi del potere di innovare l’ordinamento giuridico e nemmeno valore provvedimentale, poiché non hanno come destinatari soggetti estranei all’amministrazione, ma costituiscono atti diretti agli organi ed uffici periferici sottordinati con cui l’Amministrazione fornisce indicazioni interpretative e istruzioni circa le modalità con cui dovranno comportarsi i propri dipendenti ed uffici.
I c.d. documenti di prassi pertanto non costituiscono atti amministrativi in senso proprio ma solo il mezzo per portare a conoscenza dei destinatari disposizioni interne di carattere organizzativo, interpretativo o informativo: si tratta di atti endogeni alla P.A. che hanno efficacia solo indiretta nei confronti dei rapporti con i soggetti esterni nella misura in cui possono incidere sui provvedimenti della P.A. che ne fanno applicazione.
Nella sentenza del Consiglio di Stato n.7521/2010 si osserva che “…tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione. Inoltre è evidente che tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre per gli organi destinatari essi sono vincolanti solo se legittimi, potendo essere disapplicati qualora siano contra legem”.
Nella sentenza n.5137/2014 della sezione tributaria della Cassazione si ricorda che, secondo il consolidato principio della giurisprudenza del Giudice di legittimità, “…l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge” (Cass. 11931/1995, 14619/2000, 21154/2008).
Da tanto consegue che la violazione delle disposizioni contenute in un atto di prassi non necessariamente comporta il vizio di eccesso di potere, e quindi di annullabilità, del provvedimento amministrativo emesso, e questo perché l’atto di prassi, in quanto atto interno della P.A., non può disporre contra legem onde esso deve essere disatteso dal funzionario competente se manifestamente illegittimo.
Consegue altresì che il soggetto nei cui confronti sia emesso un provvedimento amministrativo in applicazione di un atto di prassi illegittimo non ha alcun onere né possibilità di impugnare l’atto di prassi, ma può limitarsi a contestarne la legittimità allo scopo di sostenere che il provvedimento che ne ha fatto applicazione è illegittimo perché scaturito da un illegittimo atto di prassi che avrebbe dovuto essere disapplicato (Cons Stato sent. 2768/2005).
Invero l’esclusione della possibilità di impugnare il documento di prassi deriva dalla inesistenza, nel soggetto che impugna il provvedimento, di un interesse diretto alla impugnazione del documento predetto e dal difetto assoluto di giurisdizione, non essendo consentito ad alcun giudice intervenire su un atto interno della P.A. poiché diversamente sarebbe violata l’autonomia interna della stessa ( v. Cass. S.U. 23031/2007).
Pertanto il giudice investito dell’impugnazione di un provvedimento emesso in esecuzione di un documento di prassi illegittimo dovrà limitarsi a disapplicare anche di ufficio il detto illegittimo documento (Consiglio di Stato sent. 1894/2003).
L’unico effetto esterno di un illegittimo documento di prassi è quello previsto dall’art.10 della L.n.212/2000 (Statuto del Contribuente) che esclude l’applicabilità di sanzioni ed interessi nei confronti del contribuente che “si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria”.
9) I documenti di prassi e il dovere di obbedienza
Come si è già detto i c.d documenti di prassi, e segnatamente quelli con i quali “l’Amministrazione Finanziaria interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione” (così Cass. S.U. sent. 23031/2007) parere che non genera alcun vincolo verso l’esterno, ovvero verso il contribuente o verso il giudice che sia chiamato a conoscere del provvedimento illegittimo emesso in applicazione di un illegittimo documento di prassi.
Più delicata si rivela la soluzione in ordine alla vincolatività per gli uffici gerarchicamente subordinati di un documento di prassi (es. una Direttiva) con cui sia fornita l’interpretazione illegittima di una norma di legge.
Al problema risulta data soluzione nella cit. sentenza delle S.U. n.23031/2007 nel senso che la circolare emanata nella materia tributaria non vincola “gli uffici gerarchicamente subordinati, ai quali non è vietato disattenderla (evenienza questa che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica) senza che per questo il provvedimento adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso ecc.) possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare”, e “non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata , la quale resta libera di modificare, correggere ed anche completamente disattendere l’interpretazione adottata”.
La soluzione, certamente condivisibile, richiede però qualche chiarimento.
Se è vero, infatti, che nell’ambito della P.A. non sussiste un vero e proprio rapporto di gerarchia (tipo militare) tra gli organi superiori e quelli subordinati poiché i primi non emettono ordini nei confronti dei secondi ma solo atti c.d. di prassi (Circolari, Direttive, Risoluzioni) ovvero atti a mezzo dei quali si indicano, anche mediante l’interpretazione della legge, gli obiettivi da raggiungere, lasciando discrezionalità per i mezzi, e se è pur vero che non esiste (come meglio si dirà di seguito) un obbligo incondizionato di eseguire gli ordini dei superiori (anche se illegittimi), tuttavia non può ignorarsi del tutto la rilevante funzione delle direttive che resta pur sempre quella di assicurare l’uniformità di comportamento nell’azione della P.A. verso i terzi e di evitare, pertanto, che i vari uffici subordinati le disattendano senza alcuna motivazione, dando così luogo ad un inammissibile sistema anarchico nella gestione della attività della P.A.
La soluzione al problema è data dall’art.17 del DPR n.3 del 1957 (T.U. sul pubblico impiego) il quale, disponendo una deroga per l’impiegato al dovere di eseguire gli ordini che gli siano impartiti relativamente alle proprie funzioni o mansioni posto dall’art.16, testualmente dispone che “L’impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
L’omesso esercizio dell’obbligo di rimostranza comporta l’inapplicabilità dell’esimente prevista dall’art.18 T.U. cit. (secondo il quale non risponde dei danni verso la P.A. l’impiegato che ha l’obbligo di eseguire l’ordine sussistendo la responsabilità del superiore gerarchico che impartì l’ordine illegittimo), configura colpa dell’impiegato e rileva ai fini della responsabilità patrimoniale per l’eventuale danno derivato all’erario.
E’ stato pertanto ritenuto che “Non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il c.d. dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto. Qualora ricorra un’evenienza del genere, il pubblico impiegato ha tuttavia l’obbligo di fare una immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l’ordine e se quest’ultimo è ribadito per iscritto allora il dipendente non può esimersi dall’eseguirlo, a meno che l’esecuzione configuri un’ipotesi di reato”. (Cons. di Stato sent. n.6208/2008).
10) Provvedimento illegittimo e autotutela dell’A.F.
Nell’ipotesi che sia emesso un provvedimento tributario facendo applicazione di un documento di prassi contrastante con norme di legge, l’A.F., dopo averne riscontrato la illegittimità o infondatezza, di ufficio o anche su istanza del contribuente, facendo uso del potere di autotutela può eliminarlo del tutto o anche rinnovarlo previa eliminazione dei vizi riscontrati.
Il fondamento del potere di autotutela si rinviene negli artt. 97, 23 e 53 della Costituzione che pongono i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., della imponibilità solo per legge dei tributi e della capacità contributiva.
Quanto alla obbligatorietà o meno dell’esercizio del potere di autotutela va innanzitutto premesso che, in caso di istanza motivata del contribuente, non sembra dubbio che l’A.F. abbia l’obbligo di fornire una risposta entro il termine di giorni 30, ex L.241/1990. Inoltre, per le considerazioni che di seguito sono esposte, e nonostante autorevoli decisioni giurisprudenziali affermino la natura discrezionale dell’esercizio del potere di autotutela, si ritiene che l’annullamento in autotutela di un provvedimento illegittimo sia doveroso con l’unica eccezione relativa a vizio già dedotto e coperto dal giudicato (ex art.2 D.M. 37/97).
Invero l’obbligo dell’A.F. di annullare in autotutela i suoi provvedimenti tributari illegittimi si evince non solo dalla Costituzione (art. 97 principi di buon andamento e di imparzialità della P.A.) ma anche dalla legge (art.1 L. 241/90 principio di legalità, e art.10 L.212/2000, principi di collaborazione e buona fede) e dagli stessi provvedimenti adottati dal MEF per dare applicazione al DM 37/97 che detta proprio la disciplina dell’autotutela.
Invero con l’art.2 quater del D.L. 564/1994 (conv. in L. 656/1994) fu disposto che con decreti del MEF fossero indicati gli organi dell’Amministrazione Finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati. Fu in particolare disposto che “Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’amministrazione”.
Con il successivo decreto n.37/97 del Ministro delle Finanze (artt.7 e 8) furono definiti i “criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa”, indicandosi tra l’altro “la giurisprudenza consolidata nella materia, il criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio…l’esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse”.
Con la Circolare n.198/1998 del MEF (Uff. Coscienza Civica Serv. di Coordinamento) fu disposto che “…è indubbio che l’ufficio stesso non possiede un potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori. Infatti da un lato il mancato esercizio dell’autotutela nei confronti di un atto patentemente illegittimo, nel caso sia ancora aperto o comunque esperibile il giudizio, può portare alla condanna alle spese dell’amministrazione con conseguente danno erariale (la cui responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sul dirigente e responsabile del mancato annullamento dell’atto); dall’altro…è evidente che l’esercizio corretto e tempestivo dell’autotutela viene considerato dall’amministrazione non certo come una specie di optional che si può attivare o non attivare a propria discrezione, ma come una componente del corretto comportamento del dirigente degli uffici e quindi come un elemento di valutazione della loro attività dal punto di vista disciplinare e professionale”.
Alcuni anni dopo, con la Circolare MEF n.22/E del 26 maggio 2011, fu previsto che prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado fosse valutato, previo esame dei motivi di ricorso, il grado o rating di sostenibilità della controversia, al fine di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per l’autotutela o per la conciliazione giudiziale, totale o parziale. Fu espressamente disposto che “va esercitata l’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio”.
Con la Direttiva n.48/2012 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale degli Affari Legali, rammentava ai funzionari delle sedi delegate che il tempestivo intervento finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo, mediante lo strumento dell’autotutela, consente di limitare i costi del contenzioso, riduce il rischio di soccombenza e condanna alle spese di lite ed evita, conseguentemente, la responsabilità diretta del funzionario titolare del procedimento.
In una lettera inviata nel maggio 2011 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (dr. Befera) tutti i dipendenti erano invitati ad operare con correttezza ed efficienza e richiamati alle proprie responsabilità con la precisazione che l’azione di controllo si rivela efficace solo se corretta e non quando esprime arroganza o sopruso o comunque comportamento non ammissibile nell’ottica di una corretta e civile dialettica, ribadendo le conseguenze non solo disciplinari, ma anche risarcitorie del comportamento arrogante o negligente dei dipendenti.
Con la nota n.21516/2012 il Direttore dell’A.E. rammentava agli uffici periferici che l’utilizzo dell’autotutela non corrisponde ad una mera facoltà residuale del funzionario amministrativo, ma ad un dovere della P.A., dovere a cui sono collegate precise responsabilità e un metodo con cui attuare i principi di civiltà giuridica contenuti nell’ordinamento tributario mediante la rimozione degli atti illegittimi al fine di migliorare i rapporti di tax compliance con i contribuenti.
Sulla responsabilità della P.A. per l’omesso annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi si pronunciava anche la Corte di Cassazione che nella sentenza n.1710/2007 rilevava che l’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela risponde alla salvaguardia degli interessi erariali ed al ripristino della legalità violata, legalità connessa con una giusta tassazione, rispettosa dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di esercizio imparziale della funzione tributaria, principi che sono costituzionalmente garantiti, che informano il corretto e leale rapporto tra Amministrazione e cittadino identificando il corretto agere pubblico finalizzato alla creazione di un rapporto di effettiva collaborazione e lealtà.
Successivamente (Cass. 698/2010) veniva riconosciuta la risarcibilità “del danno sopportato da un soggetto per ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l’atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che si riferiscono ad un procedimento amministrativo…il danno di cui si chiede il risarcimento in realtà deriva dal compimento dell’atto illegittimo…essendo l’intervento in autotutela solo il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della PA. permane ed è innegabile”.
11) Il risarcimento del danno per l’atto tributario illegittimo
Da antica data (S.U. sent..722/1999) ed anche di recente (S.U. 15593/2014 e 20426/2016) la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “L’attività della P.A., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo della legge, ma anche dalla norma primaria del neminem ledere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall’art.97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art.2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario Cass. S.U. 5477/1955)”.
Una volta stabilito il principio che anche l’Amministrazione finanziaria deve rispettare la regola del neminem ledere posta dall’art.2043 c.c., onde l’emanazione di illegittimi provvedimenti tributari comporta l’obbligo della stessa di risarcire i danni provocati, resta da stabilire quale sia il giudice avente giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni e come siano quantificabili i danni stessi.
Va ricordato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta e che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale che deve essere individuato in funzione della causa pretendi ovvero con riferimento alla natura della posizione dedotta in giudizio ed alla protezione accordata in astratto ad essa dal diritto.
Consegue che se in giudizio è dedotta una lesione patrimoniale conseguente ad un illecito comportamento dell’amministrazione finanziaria per un rapporto tributario già esaurito, non sussistendo alcuna attuale connessione tra questo e la lesione patrimoniale, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario, poiché la domanda non investe il rapporto tributario, requisito questo necessario al fine di ritenere sussistente la giurisdizione tributaria, pena la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali ( S.U. 20323/2012 e 3773/2014).
Nella diversa ipotesi, invece, che la pretesa risarcitoria avanzata presenti un nesso causale immediato e diretto con il rapporto tributario impugnato che non sia esaurito ma anzi costituisca l’oggetto del giudizio, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice tributario poiché la predetta domanda risarcitoria deve essere ricondotta nell’ambito dell’art.96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata, norma che, come già autorevolmente ritenuto (S.U. 13899/2013) “a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n.546/92; b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art.2043 cod. civ., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre Cass. 28226/2008 e 5069/2010); c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass.9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010)”.
Di fatto il dictum della Suprema Corte è stato recepito dal legislatore che, con l’inserimento (effettuato con il Dlgs 156/2015 a decorrere dal 01/01/2016) del comma 2 bis nell’art.15 del Dlgs 546/92 ha espressamente disposto che nel processo tributario “Si applicano le disposizioni di cui all’art.96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile” che, disciplinando entrambe la condanna per la c.d. lite temeraria, prevedono rispettivamente: 1) la condanna, su istanza della parte avversa, oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni per colui che “ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, danni che il giudice liquida anche di ufficio; 2) la possibilità che la parte soccombente sia comunque condannata, anche di ufficio, al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata.
Orbene, mentre la seconda ipotesi di lite temeraria configura evidentemente una sanzione per la parte che abbia fatto evidente abuso del processo, non sembra possa dubitarsi che con la prima il legislatore, prendendo atto delle decisioni giurisprudenziali, abbia ufficialmente ampliato la giurisdizione tributaria in essa introducendo anche la domanda risarcitoria che sia direttamente connessa con la dichiarata illegittimità del provvedimento tributario.
Si è verificato, nell’ambito della giurisdizione tributaria, fenomeno non dissimile da quanto già avvenuto nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Giova ricordare, infatti, che originariamente non era consentito al giudice amministrativo decidere sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente e che solo dopo coraggiosi interventi della Cassazione, che aveva ipotizzato la denegata giustizia nella giurisdizione amministrativa per la impossibilità di decisione sulle istanze risarcitorie proposte dal ricorrente, intervenne il legislatore che, con l’art.7, comma 4, del Dlgs 104/2010 ( C.P.A.), dispose che il G.A. può conoscere della domanda di risarcimento del danno collegato all’esercizio di un potere autoritativo.
L’ampliamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo anche alla materia risarcitoria è chiaramente giustificabile in considerazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, essendo più che evidente che il giudice che conosce l’atto illegittimo è quello più idoneo a conoscere anche dei danni da esso prodotti, evitandosi così all’utente della giustizia di adire diverse giurisdizioni con i conseguenti inevitabili sprechi di tempo e di risorse economiche, evitandosi altresì il concreto pericolo di contrasto di giudicati.
Il problema, in effetti, si poneva in termini non dissimili per il processo tributario per il quale però la giurisprudenza si dimostrava contraria per il timore che fosse violato l’art.102, secondo comma, e la VI Disp. Transit. della Costituzione che vietano l’istituzione di giudici speciali.
Trattavasi, tuttavia, di timore infondato poiché allorquando il danno sia una diretta conseguenza del provvedimento impugnato e la domanda risarcitoria sia limitata alla ipotesi di annullamento dell’atto non è ravvisabile alcuno snaturamento della giurisdizione tributaria che, in quanto avente ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ex art.2, comma 1, Dlgs.546/92, deve ricomprendere anche i diritti patrimoniali che conseguono alla dichiarazione di annullamento dell’atto tributario.
Ben si intende, però, che resta ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario nell’ipotesi che l’atto tributario sia già stato annullato indipendentemente dal G.T. o comunque che vi sia mero nesso di occasionalità tra l’atto tributario e il danno.
Giova ricordare che già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 156/2015, che ha ufficialmente introdotto nel processo tributario la c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria, era stato affermato che “Rientra nella giurisdizione tributaria la domanda diretta al risarcimento dei danni subiti per effetto dei ritardati rimborsi di imposte indebitamente versate. Il contribuente danneggiato dal ritardo dell’Amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento e deve farlo con istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente” (Cass S.U. 14499/2010) e che “Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art.96 c.p.c. potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto” (Cass. S.U. 13899/2013).
Ai fini dell’affermazione della responsabilità aggravata, che è azione speciale di risarcimento del danno ex art.2043 c.c., si richiede una precisa domanda della parte vittoriosa nonché l’esistenza, nella parte avversa, dell’elemento psicologico che consiste nell’avere azionato la propria pretesa o resistito a quella avversaria con mala fede o colpa grave, ovvero con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, oppure senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, e comunque “senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodi di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass.3376/2016).
Per quanto concerne poi l’entità dei danni subiti si rileva che l’obbligazione tributaria è pur sempre una obbligazione pecuniaria (essendo irrilevante la natura pubblica di una delle parti) per la quale trova applicazione l’art.1224 c.c. che testualmente dispone che “1) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. 2) Al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.
Orbene si rileva innanzitutto che nell’ipotesi della lite temeraria deve ritenersi sempre sussistente la mora del debitore poiché, come costantemente ed autorevolmente ritenuto da antica data “la mora del debitore presuppone solo l’attualità e l’esistenza dell’obbligazione, non rilevando invece che il credito –nell’an e nel quantum – sia o possa essere contestato dal debitore, essendo appena il caso al riguardo di rammentare che…la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in tema di pagamento. Pertanto sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell’interpellatio” (Cass.4712/1994, 9510/2014, 16797/2016).
Tanto premesso si osserva che, ricordando che l’obbligazione tributaria è una obbligazione pecuniaria, al contribuente che dimostri che, per effetto di un provvedimento tributario dichiarato illegittimo, abbia subito un pregiudizio maggiore di quello corrispondente agli interessi dovutigli deve essere riconosciuto, in base al comma secondo dell’art.1224 c.c., il maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui dimostri che la detta disponibilità lo avrebbe messo in grado di evitare o quanto meno ridurre gli effetti negativi che l’inflazione produce a carico di chi possiede denaro.
Atteso il testuale disposto della norma di cui all’art. 96, primo comma, c.p.c., ( il giudice la condanna…al risarcimento dei danni che liquida, anche di ufficio…) è da ritenere che il giudice possa liquidare, in via equitativa, anche il danno materiale (art.2043 c.c.), ulteriore rispetto a quello della rivalutazione, consistente, tra l’altro, nelle spese che normalmente si sostengono per consultare il commercialista, per le varie trasferte verso l’ufficio dell’A.F., nonché quelle accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la stessa, nonché il c.d. danno esistenziale (art.2059 c.c.) tenendo conto dello stress e patema d’animo subito dal danneggiato.
Si ricorda, infatti, che secondo l’antico, ma sempre attuale, insegnamento giurisprudenziale “una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata non è necessario che l’interessato deduca e dimostri uno specifico danno, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza” (Cass.1031/2001).
Giuseppe Di Nardo